Innamorarsi a Dublino, ma quanto è strano, assaporare il latte sulla pizza - io che sulla pizza ci bevo birra e basta- e dire pure ‘ma che buono!’. Perdere la testa qui in Irlanda, insomma, colpita a tradimento da un pugnale.
Così fa quel bastardo che detesto citare: una scintilla nella miscela animale e poi lo scoppio di una fantasia. Io penso proprio che sia questo l’amore, ma non ci giurerei, visto che non so neppure come è fatto. Ma pure ammesso che sia lui, cioè appurato che sia presa da questa fantasia …che farò domani? Cosa racconterò al mio spirito di aladino, passate queste ore di bisbigli, sonni leggeri, qualche stella in cielo? saprò distinguere tra un capriccio del senno e qualcosa di essenziale? Niente, che vuoi che faccia, mi acquatterò buona buona, e se accadrà l’amore ci penserò allora. Per ora me ne sto al buio e penso, in questa notte di equinozi, sensi di primavera, voci silenti di un’oscura magia. Ardono, in questo buio, bruciano i miei pensieri, girano un girotondo di folletti. E per favore, non scomodiamo la parola, è roba stracca, voglio solo starmene con i desideri, lievi e gentili come il sorriso del mio guerriero.
E’ venuto, ieri sera finalmente l’ho visto. Ma non c’erano massi, odore di muschi, schiaffi del vento d’oltremare. Né ho udito erba sotto i passi o visto lui che soffiava in cielo. Vecchie fandonie di storielle celtiche. Ero al pub col mio amico Salvatore quando, già alticcio di birra e anisetta, è scattato in piedi, ha fatto gesti alle mie spalle e poi, non accusando risposta, sbraitato: “Roy, brutto traditore, come and sit with us!”.
Roy. Un tuffo in petto, come picchiassero alla porta. Ha indugiato, vista la sceneggiata di Salvo o forse perché c’ero io, quindi l’ha spalancato, l’uscio, e finalmente ho visto: cupido? No, un bel sedere. Nodoso alquanto e piatto perché intuissi fosse di maschio. Il culo! insieme a un tronco asciutto e due spalle dritte, così si è rivelato questo amore. Glutei, tronco, spalle, tutta sta roba ha puntato Salvo, forse esclamato ‘hi, Sal!’ e poi battuto un cinque sul suo petto. Salvo ha barcollato, lo dico esagerando – quando è ubriaco è peggio di un pagliaccio - spiegato le sue alucce e attirato l’uomo. Allora il gas ha scintillato, schiarendo la seguente scena: natiche, schiena, spalle, golf blu notte, hanno espulso braccia con relative mani – dalle dita sottili, le nocche un poco rosse – restituendo l’amplesso. E mentre si pigliavano una guancia bionda, folta di peli, si è adagiata sull’opposta di Salvo a bisbigliare. In quel momento, la gran fessa che sono, l’ho spiato alle gambe. E se mi insulto è perché qualcuno in testa me lo rinfacciava. Di scoparmi con gli occhi le cosce di quell’uomo: lunghe, un po’ arcuate. Storte, a essere sincera.
“Ti presento miss D’Ambros, è qui per darci una mano”.
Il Professor Salvatore Gallo si è espresso in perfetto inglese, come gli capita nelle gravi stanze dell’Istituto Manzoni di Dublino. E come faccio io? In che modo succhierò le idee a ‘sto guerriero? Al diavolo l’inglese, adesso stavo facendomi la sua barba! nel senso di scoparmi un fogliame di peli, una selva lucente per sorriso lieve e sguardo fondo più del cielo. Questo il pugnale, tale l’incendio del mio gas: due occhi belli come l’acqua e un’espressione. Da impareggiabile figlio di puttana.
Le suddette scopate hanno avvilito le idiomatiche di introduzione. Un naufragare tra baleni e scoppi (ma quanto gas avevo in corpo?), se invece di dire hi! mi è uscito un abominevole gled tu sii iu. Tu sii iu? Ma allora dillo, ammettilo che te lo fai con gli occhi, se no avresti detto mit, tu mit iu!
Il ganzo mi ha tratto a secco dal suo mare: “parlo discretamente l’italiano, non si affanni”. E mi ha sorriso dolce dolce.
“Mi scusi tanto – che ti scusi, che t’importa, scema!- mi scusi tanto, mi succede spesso…”
“Really?”
Rili? Come sarebbe a dire rili? Ma chi t’ha dato le mie chiavi? Chi ti ha mandato qui a bussare? Guarda che ti piglio a morsi, sai? io ti divoro come una cannibala polinesiana, se non la smetti di impicciare.
“Eh, mi incasino sempre introdiusing mi”, ho allora ammesso, frullando le zucchine con banane.
“Normale, capita a anche a me quando sto in Italia”.
Normale? Come sarebbe a dire? Ti sembra ovvio che io affoghi nell’acqua? Che tu mi acciuffi con la bocca? E nuotiamo insieme, noi due e nessuno, fino a sfinirci sulla riva? alcol, prendo del gin e verso. “Vado a pigliare un po’ di aria”, dice in quel mentre Salvatore. Sì, vattene un po’ fuori, vai.
“Beh, dopo otto mesi speravo di essere…di essere più brava, ecco”.
“Sogna già in inglese?”
Stretta abbarbicata al mio bicchiere, fermo a mezz’aria tra di noi. Noi due da soli.
“In inglese? Sa che non ci avevo mai pensato?”
Ha svuotato il suo, nuotandomi tra le cosce con un ammicco.
“Aspetti”, ho ripigliato, “c’ha ragione ….”.
“Cioè?”
“L’altra notte, un sogno, c’era una mia amica….si chiama Chiara”.
“E lei?”
“Lei chi? Non ho capito”.
“Il suo nome, lei, come si chiama?
“Io? E che c’entro io?”
“Semplice curiosità, ‘rabbiata?”
“Si figuri! Iz e long stori, non so se adesso…senta, faccia che mi chiamo Lalla e basta …. ‘rabbiato?”
“Buonasera Lala, mai stato meglio. Sogna già in inglese?”
“Io? Ah già, il sogno. Certo che era in inglese. Dunque, stavamo sul ponte, il ponte diii… come si chiama? quello famoso…”
“O’ Connel?”
“Forse, ma poteva essere un altro… ‘sti sogni! io quando li faccio….”
“Beviamo ?”
“Noi due? Con piacere… dicevo?”
“Il ponte”.
“…giusto. Lei era dal lato della Posta, iiiio…ennò, io ero di qua, questo è sicuro … ero versoo…”
“Aston?”
“Più o meno. Insomma, mi gridava ‘sbrigati, facciamo tardi!’, e io ferma, come se qualcuno mi tenesse, che angoscia. E non è finita. All’improvviso compare una vecchia. Sìììì, una che rideva e rideva, madò, l’avrei strozzata quanto rideva. Si è avvicinata, ha aperto bocca e sa che ha fatto?”
“Baciata?”
“Un bacio? Maddai! ce li avessi così i sogni! s’è tolta la dentiera, capisce? adesso però non mi guardi così…sa, io…”
“Non la posso guardare, Lala?”
Ma prego, accomodati, fai pure, stenditi dove vuoi. Io e te, insieme, nudi nel mare dei tuoi occhi.
“Ci mancherebbe, volevo dire che è un sogno scemo, non crede?”
“Affatto, significa che l’inglese l’hai imparato. Ops, scusami se ti ho dato del tu”.
Tu. Io. Perduti dentro noi. Non ci so nuotare in questo mare, e temo anche di affogarci. Vattene, perciò, ti adoro, sparisci dai miei sogni folletti, e se ti ostini, se mi danzi dentro nei desideri, vuoi proprio che ti dica? Sicuro sicuro? Sono un’analfabeta, ignoro la prima persona plurale, e peggio mi succede con la parola, un suono a cinque lettere e nient’altro. Intesi? Toc toc, uffa, ma guarda se capisce! tipico zuccone irlandese. T’ho detto vattene, ti adoro, non c’è posto! Toc toc, eddai! Ma sei di coccio? sogno già in inglese, ogni notte, in bianco e nero, occhei? Stop, finito, toc toc, ancora! senti, ti prego, ti amo, dimmi che sei il lattaio, o il tizio delle tasse, aspetta, mi voglio rovinare, il poliziotto che riconsegna il sacco della spesa. Tutto, mi va bene ogni cosa, purché non senta più quel tocco. Anzi, sai che ti dico? noi, noi due da soli, manco ci siamo visti, sei un gioco della mente come se ne fanno a migliaia. E perciò t’ammazzo! socchiudo gli occhi e ti immagino seduto al cesso. Honey.
Carlo Capone
Trackback: http://www.bartolomeodimonaco.it/online/?p=1864
Così fa quel bastardo che detesto citare: una scintilla nella miscela animale e poi lo scoppio di una fantasia. Io penso proprio che sia questo l’amore, ma non ci giurerei, visto che non so neppure come è fatto. Ma pure ammesso che sia lui, cioè appurato che sia presa da questa fantasia …che farò domani? Cosa racconterò al mio spirito di aladino, passate queste ore di bisbigli, sonni leggeri, qualche stella in cielo? saprò distinguere tra un capriccio del senno e qualcosa di essenziale? Niente, che vuoi che faccia, mi acquatterò buona buona, e se accadrà l’amore ci penserò allora. Per ora me ne sto al buio e penso, in questa notte di equinozi, sensi di primavera, voci silenti di un’oscura magia. Ardono, in questo buio, bruciano i miei pensieri, girano un girotondo di folletti. E per favore, non scomodiamo la parola, è roba stracca, voglio solo starmene con i desideri, lievi e gentili come il sorriso del mio guerriero.
E’ venuto, ieri sera finalmente l’ho visto. Ma non c’erano massi, odore di muschi, schiaffi del vento d’oltremare. Né ho udito erba sotto i passi o visto lui che soffiava in cielo. Vecchie fandonie di storielle celtiche. Ero al pub col mio amico Salvatore quando, già alticcio di birra e anisetta, è scattato in piedi, ha fatto gesti alle mie spalle e poi, non accusando risposta, sbraitato: “Roy, brutto traditore, come and sit with us!”.
Roy. Un tuffo in petto, come picchiassero alla porta. Ha indugiato, vista la sceneggiata di Salvo o forse perché c’ero io, quindi l’ha spalancato, l’uscio, e finalmente ho visto: cupido? No, un bel sedere. Nodoso alquanto e piatto perché intuissi fosse di maschio. Il culo! insieme a un tronco asciutto e due spalle dritte, così si è rivelato questo amore. Glutei, tronco, spalle, tutta sta roba ha puntato Salvo, forse esclamato ‘hi, Sal!’ e poi battuto un cinque sul suo petto. Salvo ha barcollato, lo dico esagerando – quando è ubriaco è peggio di un pagliaccio - spiegato le sue alucce e attirato l’uomo. Allora il gas ha scintillato, schiarendo la seguente scena: natiche, schiena, spalle, golf blu notte, hanno espulso braccia con relative mani – dalle dita sottili, le nocche un poco rosse – restituendo l’amplesso. E mentre si pigliavano una guancia bionda, folta di peli, si è adagiata sull’opposta di Salvo a bisbigliare. In quel momento, la gran fessa che sono, l’ho spiato alle gambe. E se mi insulto è perché qualcuno in testa me lo rinfacciava. Di scoparmi con gli occhi le cosce di quell’uomo: lunghe, un po’ arcuate. Storte, a essere sincera.
“Ti presento miss D’Ambros, è qui per darci una mano”.
Il Professor Salvatore Gallo si è espresso in perfetto inglese, come gli capita nelle gravi stanze dell’Istituto Manzoni di Dublino. E come faccio io? In che modo succhierò le idee a ‘sto guerriero? Al diavolo l’inglese, adesso stavo facendomi la sua barba! nel senso di scoparmi un fogliame di peli, una selva lucente per sorriso lieve e sguardo fondo più del cielo. Questo il pugnale, tale l’incendio del mio gas: due occhi belli come l’acqua e un’espressione. Da impareggiabile figlio di puttana.
Le suddette scopate hanno avvilito le idiomatiche di introduzione. Un naufragare tra baleni e scoppi (ma quanto gas avevo in corpo?), se invece di dire hi! mi è uscito un abominevole gled tu sii iu. Tu sii iu? Ma allora dillo, ammettilo che te lo fai con gli occhi, se no avresti detto mit, tu mit iu!
Il ganzo mi ha tratto a secco dal suo mare: “parlo discretamente l’italiano, non si affanni”. E mi ha sorriso dolce dolce.
“Mi scusi tanto – che ti scusi, che t’importa, scema!- mi scusi tanto, mi succede spesso…”
“Really?”
Rili? Come sarebbe a dire rili? Ma chi t’ha dato le mie chiavi? Chi ti ha mandato qui a bussare? Guarda che ti piglio a morsi, sai? io ti divoro come una cannibala polinesiana, se non la smetti di impicciare.
“Eh, mi incasino sempre introdiusing mi”, ho allora ammesso, frullando le zucchine con banane.
“Normale, capita a anche a me quando sto in Italia”.
Normale? Come sarebbe a dire? Ti sembra ovvio che io affoghi nell’acqua? Che tu mi acciuffi con la bocca? E nuotiamo insieme, noi due e nessuno, fino a sfinirci sulla riva? alcol, prendo del gin e verso. “Vado a pigliare un po’ di aria”, dice in quel mentre Salvatore. Sì, vattene un po’ fuori, vai.
“Beh, dopo otto mesi speravo di essere…di essere più brava, ecco”.
“Sogna già in inglese?”
Stretta abbarbicata al mio bicchiere, fermo a mezz’aria tra di noi. Noi due da soli.
“In inglese? Sa che non ci avevo mai pensato?”
Ha svuotato il suo, nuotandomi tra le cosce con un ammicco.
“Aspetti”, ho ripigliato, “c’ha ragione ….”.
“Cioè?”
“L’altra notte, un sogno, c’era una mia amica….si chiama Chiara”.
“E lei?”
“Lei chi? Non ho capito”.
“Il suo nome, lei, come si chiama?
“Io? E che c’entro io?”
“Semplice curiosità, ‘rabbiata?”
“Si figuri! Iz e long stori, non so se adesso…senta, faccia che mi chiamo Lalla e basta …. ‘rabbiato?”
“Buonasera Lala, mai stato meglio. Sogna già in inglese?”
“Io? Ah già, il sogno. Certo che era in inglese. Dunque, stavamo sul ponte, il ponte diii… come si chiama? quello famoso…”
“O’ Connel?”
“Forse, ma poteva essere un altro… ‘sti sogni! io quando li faccio….”
“Beviamo ?”
“Noi due? Con piacere… dicevo?”
“Il ponte”.
“…giusto. Lei era dal lato della Posta, iiiio…ennò, io ero di qua, questo è sicuro … ero versoo…”
“Aston?”
“Più o meno. Insomma, mi gridava ‘sbrigati, facciamo tardi!’, e io ferma, come se qualcuno mi tenesse, che angoscia. E non è finita. All’improvviso compare una vecchia. Sìììì, una che rideva e rideva, madò, l’avrei strozzata quanto rideva. Si è avvicinata, ha aperto bocca e sa che ha fatto?”
“Baciata?”
“Un bacio? Maddai! ce li avessi così i sogni! s’è tolta la dentiera, capisce? adesso però non mi guardi così…sa, io…”
“Non la posso guardare, Lala?”
Ma prego, accomodati, fai pure, stenditi dove vuoi. Io e te, insieme, nudi nel mare dei tuoi occhi.
“Ci mancherebbe, volevo dire che è un sogno scemo, non crede?”
“Affatto, significa che l’inglese l’hai imparato. Ops, scusami se ti ho dato del tu”.
Tu. Io. Perduti dentro noi. Non ci so nuotare in questo mare, e temo anche di affogarci. Vattene, perciò, ti adoro, sparisci dai miei sogni folletti, e se ti ostini, se mi danzi dentro nei desideri, vuoi proprio che ti dica? Sicuro sicuro? Sono un’analfabeta, ignoro la prima persona plurale, e peggio mi succede con la parola, un suono a cinque lettere e nient’altro. Intesi? Toc toc, uffa, ma guarda se capisce! tipico zuccone irlandese. T’ho detto vattene, ti adoro, non c’è posto! Toc toc, eddai! Ma sei di coccio? sogno già in inglese, ogni notte, in bianco e nero, occhei? Stop, finito, toc toc, ancora! senti, ti prego, ti amo, dimmi che sei il lattaio, o il tizio delle tasse, aspetta, mi voglio rovinare, il poliziotto che riconsegna il sacco della spesa. Tutto, mi va bene ogni cosa, purché non senta più quel tocco. Anzi, sai che ti dico? noi, noi due da soli, manco ci siamo visti, sei un gioco della mente come se ne fanno a migliaia. E perciò t’ammazzo! socchiudo gli occhi e ti immagino seduto al cesso. Honey.
Carlo Capone
Trackback: http://www.bartolomeodimonaco.it/online/?p=1864
TAGS:


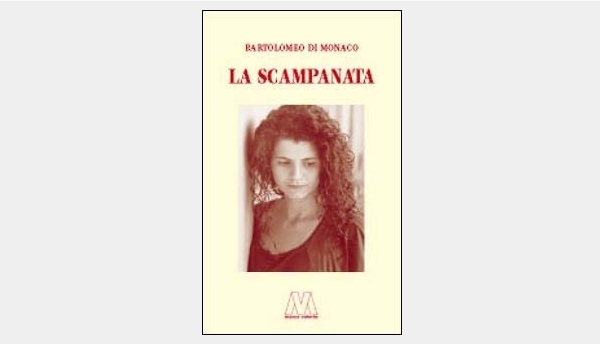
 In questo periodo, settimana santa, mi viene sempre in mente un ricordo di molti anni fa.
In questo periodo, settimana santa, mi viene sempre in mente un ricordo di molti anni fa.
 Procedimento
Procedimento 

 E’ piena estate, fa caldo, il tentativo di dormire in un'afosa notte agostana è interrotto dal ferreo suono del maestoso campanile che sovrasta la piazza vuota.
E’ piena estate, fa caldo, il tentativo di dormire in un'afosa notte agostana è interrotto dal ferreo suono del maestoso campanile che sovrasta la piazza vuota.  Questo sugo è chiamato “alla genovese”, perché pare sia stato preparato per la prima volta alla fine del 1400 da certi cuochi genovesi che aprirono una taverna a Napoli alla Loggia di Genova, zona a ridosso del porto, dove la colonia genovese, di stanza a Napoli, si amministrava autonomamente.
Questo sugo è chiamato “alla genovese”, perché pare sia stato preparato per la prima volta alla fine del 1400 da certi cuochi genovesi che aprirono una taverna a Napoli alla Loggia di Genova, zona a ridosso del porto, dove la colonia genovese, di stanza a Napoli, si amministrava autonomamente. 






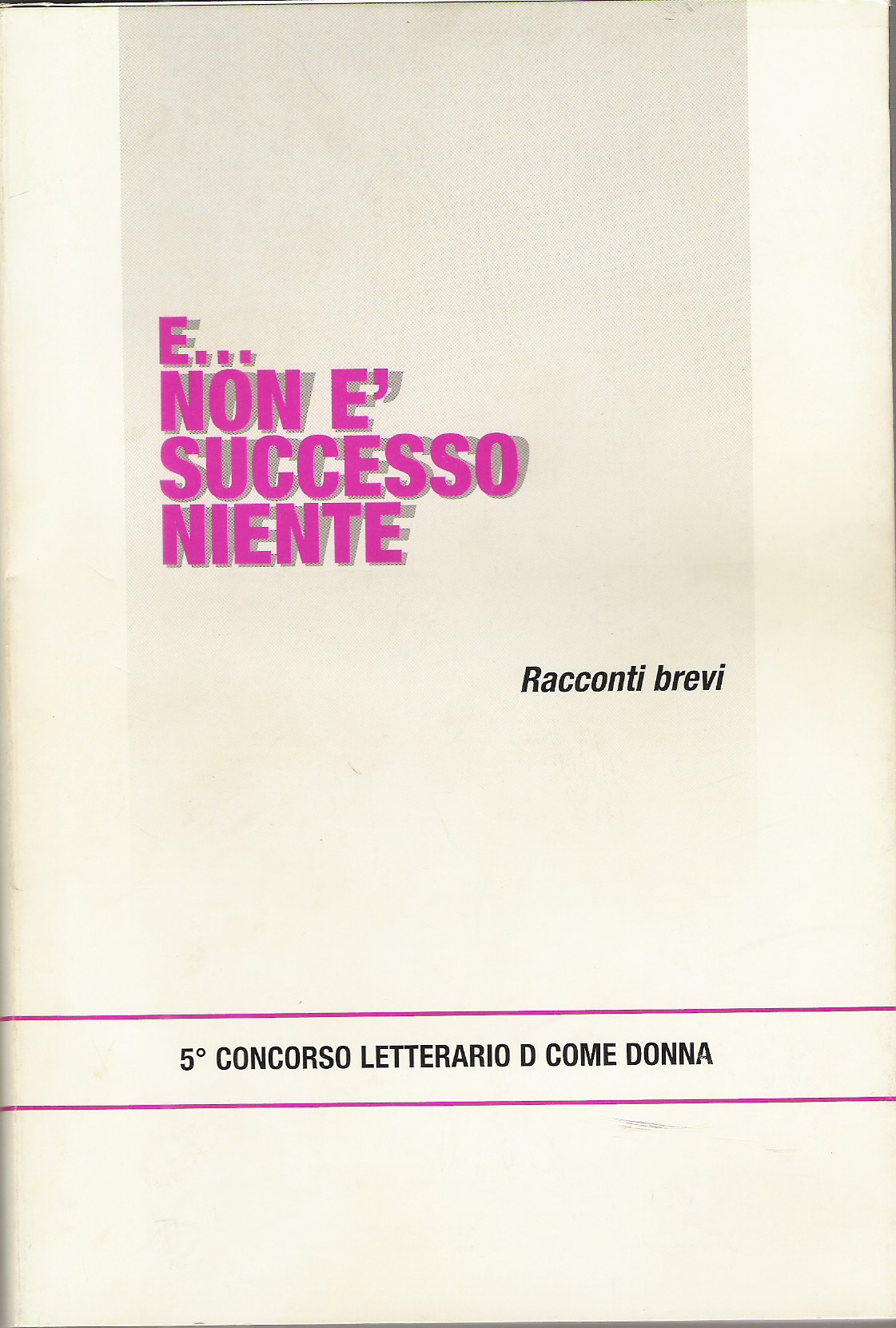 pubblicato nel volume "E... non è successo niente",
pubblicato nel volume "E... non è successo niente", Da un mondo all'altro
Da un mondo all'altro
 Claudio Bianchi ha pubblicato:
Claudio Bianchi ha pubblicato: 
 Farina
Farina
 Dosi per un impasto indiretto (col metodo del poolish ) :
Dosi per un impasto indiretto (col metodo del poolish ) :